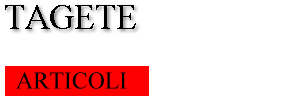
|
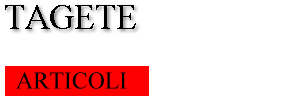
|
|
|
|
La responsabilità
medica secondo il diritto vivente |
|
|
La medicina, un tempo definita arte di Ippocrate, oggi a buon diritto può essere ritenuta una scienza anche se, per molti
aspetti ancora, empirica ma comunque sufficientemente esatta soprattutto per quelle specialità ove la ricerca è stata
incrementata anche attraverso l’applicazione di sofisticati strumenti tecnologici. Si pensi per esempio all'ecografia che ha
consentito addirittura di conoscere il sesso, le fattezze e quindi la situazione del feto mentre prima tale indagine era affidata solo
alle analisi di laboratorio, o in ortopedia alle conquiste della biomeccanica e alle protesi sempre più perfette. E’ quindi evidente
che si è persa quella immaginifica concezione della medicina come un'attività dai margini e dalle certezze approssimative e dalle
speranze sovente miracolistiche. Non per attribuire al diritto alla salute, inteso come rivalutazione della persona, più meriti di
quelli che indubbiamente già gli spettano, ma credo che anche il maggior rispetto del valore uomo ha indubbiamente
contribuito, assieme a tanti altri fattori tra i quali l’influenza dei diritti stranieri della Comunità Europea, a rivalutare anche la
responsabilità della professione sanitaria ampliandone i confini prima gelosamente custoditi da una restrittiva interpretazione
della norma codicistica di cui all’art. 2236. Non voglio entrare in un discorso che costringerebbe tutti a ripercorrere il lungo
cammino che dottrina e giurisprudenza hanno fatto da quando si riteneva che l’opera del medico, quand’anche dannosa per il
proprio paziente, comunque meritasse una sorta di viatico scriminante ma per poter affrontare, su basi concrete, il discorso
circa la responsabilità medica e in particolare del primario, è opportuno brevemente visitare i siti giurisprudenziali più
significativi che hanno condizionato, quale diritto vivente, l’attuale concezione della responsabilità del professionista medico.
E’ infatti necessario inquadrare a che titolo di responsabilità il medico, quale è sempre il Primario, deve rispondere. Credo di non sbagliare se limito l’argomento di indagine a due sentenze che penso costituiscano i punti salienti della evoluzione giurisprudenziale: Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 Maggio 1971 n. 1282 (in Foro It. 1972, I° 1476), hanno ritenuto che la responsabilità dell’Ente Ospedaliero e del medico dipendente per i danni subiti da una paziente, “può essere affermata solo se risulti che l’autore del fatto lesivo abbia agito con dolo o colpa grave”. Al di là del caso di specie, che riguardava tra l’altro anche un problema di giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo in relazione al T. U. 10/1/1957 n. 3 sul Pubblico Impiego, quello che le Sezioni Unite hanno disaminato e risolto era in pratica il problema del concorso tra le diverse ipotesi di responsabilità da fatto illecito, per la colpa commessa dal medico-agente, e contrattuale per l’ente dal quale il medico dipendeva, problema che in pratica si è dibattuto e si dibatte ancora oggi perché, prescindendo dagli aspetti pratici che non sempre risultano modificati per l’un tipo o l’altro di responsabilità, era ed è difficile chiamare contrattuale il rapporto che si instaura tra il medico ospedaliero, non espressamente eletto dal paziente, e il paziente stesso, risultando più naturale ed evidente che costui debba rispondere solo a titolo aquiliano mentre naturale è, superati i problemi di ordine pubblicistico che il servizio nazionale di sanità ha indotto, definire contrattuale il rapporto tra paziente e struttura ospedaliera e quindi inquadrabile la discendente responsabilità nell’ambito dell’art. 2236 Cod. Civ.. Il problema, più di prassi che di merito, si accentrava sul diverso decorso delle prescrizioni e sul diverso regime dell’onere probatorio, e soprattutto sulla possibilità del concorso dei due diversi tipi di responsabilità. La sentenza sopra richiamata afferma però : “tuttavia un più attento esame convince che l’art. 2236 Cod. Civ., può e deve trovare applicazione oltre che nel campo contrattuale anche in quello extracontrattuale, in quanto che esso prevede un limite di responsabilità per la prestazione dell’attività dei professionisti in generale, cioè sia che essa si svolga nell’ambito di un contratto e costituisca perciò adempimento di un'obbligazione contrattuale, sia che venga riguardata al di fuori di un rapporto contrattuale vero e proprio e perciò solo come possibile fonte di responsabilità extracontrattuale” ritenendo quindi che, al di là del contratto formale che sempre si instaura tra professionista e cliente con il conferimento dell’incarico o con la elezione del rapporto fiduciario, quello che rileva per l’assemblea plenaria della Suprema Corte è l’attività che di fatto, e quindi sostanzialmente, viene prestata in favore del malato che, con particolare riguardo alla professione medica, costituisce “la fonte prima” del vincolo contrattuale. In tal modo si sono unificate le due diverse responsabilità che prima venivano addebitate ai due diversi soggetti, pubblico e privato, colmando anche quelle diversità di trattamento processuale che comportavano una diversa concezione del problema giuridico di individuazione della responsabilità. In passato si era propensi ad agire contro l’Ente Ospedaliero e contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale in virtù del rapporto di rappresentanza che lega il medico all’ospedale e quindi in forza di quei principi di responsabilità che poi il Codice Civile del 1942 ha enunciato negli artt. 2049 e 1228 (Introna – La Responsabilità Professionale nell’esercizio delle arti sanitarie- Cedam 1955, pag. 340). In un passato ormai remoto si sono avute decisione della Suprema Corte che hanno, pur nell’altalenanza tra il concorso delle due responsabilità da fatto illecito e contrattuale e quella squisitamente contrattuale, ritenuto comunque solidale la responsabilità dei due soggetti debitori, medico e ospedale, avendo quale fonte comune il vincolo di subordinazione dell’uno rispetto all’altro (Cass. Sez. Un. 12/5/1938; Cass. Civ. 20/1/1933). Con la sentenza del 1971 si è aperta la via invece all’azione diretta di responsabilità unificata tra l’operatore e il suo mandante. Anche se le Sezioni Unite non affrontavano il problema, perché non era ancora la materia regolata dalla L. 23/12/1978 n. 833, quello che in nuce viene affermato è il principio della immedesimazione organica che è esattamente il contrario del principio della cd. responsabilità oggettiva o di riflesso. Numerose ulteriori decisioni di merito o di legittimità si sono succedute poi nell’arco di questi venti anni e più rimbalzando tra conferme e reviremant (Cass. Civ. sez. Lav. 7/8/1982 n. 4437; Cass. Civ. Sez. Lav. 23/6/1994 n. 6064; Cass. Civ. Sez. III 11/4/1995 n. 4152; Cass. Civ. Sez. III 12/8/1995 n. 8845; Cass. Civ. Sez. III 18/11/1997 n. 11440; Cass. Civ. Sez. III 1//3/1998 n. 2144; Cass. Civ. Sez. III 8/3/1999 n. 1441), ma pressappoco il principio è rimasto invariato pur se in qualche caso si è giunti, per giustificare l'omogenea responsabilità contrattuale tra medico e Ente Ospedaliero, a definire il rapporto intercorrente con il paziente come un contratto con effetti protettivi (Cass. Civ. Sez. III 22/11/1993 n. 11503). Non deve sorprendere il colpo di coda che la recentissima sentenza 13/3/1998 n. 2750 (Resp. Civ. e Prev. 1999, 272) della III Sezione Civile della Cassazione sembra aver dato definendo extracontrattuale la responsabilità di un medico per i danni causati ad un paziente nell’ambito di una struttura ospedaliera. Leggendo infatti la motivazione ci si rende conto che la Corte si è posta il problema di tale inquadramento di responsabilità ma ha dovuto soprassederne dalla disamina perché il punto era assorbito dall’accertamento insindacabile fatto dalla corte di merito sul grado della colpa del sanitario, però ha enunciato incidentalmente i presupposti per i quali tale responsabilità non si sarebbe potuta definire extracontrattuale. Infatti, appena ne ha avuto l’occasione, la stessa III Sezione, sempre presieduta da S. Ecc.za Bile, con la nota sentenza 22/1/1999 n. 589 (Resp. Civ. e Prev. 1999, 652) ha risolto il quesito riportandosi nell’alveo già tracciato più di un lustro prima dalle Sezioni Unite del 1971 definendo di natura contrattuale la responsabilità del medico dipendente del Servizio Sanitario, “ancorché non fondata su contratto ma sul contatto sociale connotato dall’affidamento che il malato pone nella professionalità dell’esercente una professione protetta” e quindi richiamando anche la definizione di contratto con effetti protettivi adottata più di vent’anni prima dalle Sezioni Unite del ’71. Quello che secondo la Cassazione rileva per definire la natura del rapporto non è la fonte dell’obbligazione, cioè il contratto direttamente o meno instauratosi tra il medico e il paziente, quanto e soprattutto il contenuto del rapporto che inevitabilmente per quanto obbligatoriamente s'instaura tra i due. La motivazione della sentenza è di estremo interesse perché in pratica è una rilettura operata in chiave critica dei vari istituti che regolano, sia sotto l’aspetto dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi, il rapporto tra servizio sanitario e il cittadino. Sarebbe troppo lungo discutere della logica giuridica che ha sorretto i giudici della terza civile nella decisione, per cui basterà prenderne in considerazione alcuni punti salienti che poi serviranno anche nell’ulteriore svolgimento del tema trattato in riferimento alle varie ipotesi di responsabilità del medico. La Suprema Corte, tra tutte le altre considerazioni svolte per escludere che il medico dipendente della struttura sanitaria possa rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale, in modo particolare evidenzia quella per la quale sarebbe necessaria non tanto la violazione di precetti quanto e soprattutto l’esistenza di un danno ingiusto per cui, laddove non vi sia un contatto diretto, l’errore commesso per negligenza, imprudenza o imperizia resterebbe irrisarcito qualora non si fosse verificata una lesione e quindi un danno ma solo la mancata guarigione che non costituendo un peggioramento rispetto allo status quo ante, non rappresenta la violazione del principio del neminem laedere. Ricordiamoci di questa affermazione che verrà utile poi per dimostrare come invece, anche laddove non si sia conseguito il risultato sperato, pur tuttavia vi è la lesione del diritto alla salute, che trova tutela secondo il principio ormai radicato nel nostro ordinamento in forza di quel diritto vivente cui la Corte Suprema ha fatto e continua a fare riferimento. La Cassazione utilizza il diritto alla salute anche per arrivare a concludere che quand’anche non vi sia un contratto diretto tra medico ospedaliero e paziente, pur tuttavia si instaura quel rapporto contrattuale di fatto da semplice contatto sociale nascente da “un'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto”, come l’ha definita Castronuovo, per la quale rientra nei doveri del medico curante, quand’anche dipendente di una struttura pubblica perché operatore di una professione cd. protetta, tutelare quei beni costituzionalmente garantiti primo tra i quali il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione. E’ quindi il venir meno di quella che mi azzardo a definire obbligazione naturale ( non nel senso di senza tutela ma come fondamentale dovere), che determina la responsabilità del medico qualora non presti, nell’opera che di fatto ha assunto, quella diligenza proporzionale alla difficoltà della materia senza commettere imprudenze e imperizie. Dando quindi per scontato che con la creazione del Servizio Sanitario Nazionale si sia di fatto instaurato non un rapporto pubblicistico tra l’interesse legittimo del paziente ad essere curato e la struttura che lo Stato gli offre, ma un contratto vero e proprio che trae origine dalla legge e quindi fa nascere diritti e doveri dalla inadempienza dei quali risulta la lesione del diritto soggettivo alla salute, ne deriva che la cura che viene prestata dal medico immedesimato organicamente con la struttura pubblica ha identica natura contrattuale, in forza del semplice contatto sociale che avviene nel momento stesso in cui di fatto il sanitario presta l’opera che gli è demandata dalla pubblica autorità in favore del malato terzo contraente e destinatario della prestazione stessa. Inquadrando in tal modo l’ambito delle due responsabilità, che si assommano necessariamente nell’unica norma codificata che possa servire alla bisogna, cioè l’art. 2236 c.c., la Cassazione giunge a parificare le due azioni prima diverse che potevano essere intentate nei confronti dei due diversi soggetti responsabili, in quanto, essendo unitario il concetto di colpa contenuto nell’art. 1176 c.c. con riferimento alla diligenza richiesta secondo la natura della attività esercitata, la responsabilità avrà rilievo quando tale dovere di diligenza, non più media ma proporzionale alla difficoltà del problema, venga violato per imprudenza e negligenza mentre la limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave resta solo in relazione alla perizia con cui si sono affrontati problemi tecnici di particolare difficoltà. Risulta subito evidente come tutto l’elaborato della Cassazione serva, al di là della chiarezza fatta sul punto, soprattutto per la gestione delle azioni risarcitorie che prima erano condizionate dall’onere della prova a carico del danneggiato da fatto illecito di natura extracontrattuale e dalla breve durata della prescrizione quinquennale. Trattandosi di responsabilità contrattuale, condizionata da quel principio di diligenza che secondo alcuni autori rappresenta il fine dell’obbligazione assunta dal medico (Stanzione, Zambrano - Attività Sanitaria e responsabilità civile – Giuffrè Ed. 1998, 16), spetterà al paziente provare che l’intervento era di facile o rutinaria esecuzione mentre il professionista dovrà dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, di aver adottato la diligenza richiesta in simili casi o che nonostante tutto, per le difficoltà dei problemi, il risultato non era raggiungibile. In pratica viene superata, anche se non disconosciuta, la differenza tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, bipolare differenziazione di origine dottrinaria, posto che nei casi di interventi di facile esecuzione è la stessa evidenza delle cose che denuncia la negligenza, nel senso che laddove un intervento è rutinario, con un risultato quasi scontato, è facile desumere la violazione dei principi di buona norma qualora detto risultato non sia raggiunto. Afferma la Cassazione, e questo è praticamente il punto conclusivo di tutto il suo costrutto logico giuridico, che “omologate le responsabilità della struttura sanitaria e del medico come responsabilità entrambe di natura contrattuale, sia ai fini della rilevanza del grado della colpa che della ripartizione dell’onere probatorio, non esiste una differenza di posizione tra i due soggetti, né per effetto di una diversa posizione del paziente a seconda che agisca nei confronti dell’Ente Ospedaliero o del medico dipendente”. Si potrà condividere o meno il dettato della Suprema Corte, richiamato immediatamente dopo da una quasi identica sentenza edita dallo stesso relatore Dott. Segreto il 19/5/1999 n. 4852 (Guida al Diritto n. 30 31/7/1999 pag. 63), ma ciò che conta è che essendo omologa la responsabilità dell’ente e del medico, omologhe sono le azioni ai fini dell’onere probatorio e della prescrizione che il danneggiato potrà proporre nei confronti dell’uno, dell’altro o di tutti e due i soggetti eliminandosi così quelle incertezze sulla scelta delle azioni da proporsi e contro chi. Avevo richiamato l’attenzione sui due punti della motivazione della sentenza esaminata che trattano, per giustificare l’esistenza di quell’obbligo-dovere che condiziona l’opera sanitaria sino a farla assurgere a una sorta di contratto di fatto, del diritto alla salute perché è proprio intorno a tale principio che a mio avviso vi possono essere delle ulteriori considerazioni da svolgere. Se per la giurisprudenza è necessario il danno ingiusto perché si abbia lesione del principio del neminem laedere, non è detto che tale lesione vi sia solo quando sussista un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti l’intervento medico. Infatti se è vero che il diritto alla salute è un diritto irrinunciabile e costituzionalmente protetto, e se è vero che lo Stato attraverso il Servizio Sanitario Nazionale tutela la salute del cittadino fornendogli cure, assistenza e quindi i mezzi per raggiungere tale risultato, nel momento stesso in cui viene meno tale tutela, ovvero la situazione di malattia rimane invariata perché la guarigione è impedita da una non diligente prestazione sanitaria, vi sarebbe anche in questo caso la lesione del diritto alla salute che quindi determinerebbe quel danno ingiusto protetto dall’art. 2043 c.c., deputato dal diritto vivente a regolare tale responsabilità. Che poi il rapporto intercorso sia di natura contrattuale o extracontrattuale, ha rilevanza solo limitata ai fini dell’onere probatorio e della prescrizione, perché laddove il criterio di giudizio debba essere espresso circa la diligenza, la prudenza e la perizia, al di la delle stereotipate e teoriche disquisizioni e differenziazioni di diritto, in sostanza il concetto di colpa, da cui discende l'obbligazione risarcitoria, non si modifica. Altrettanta scarsa importanza ha la differenza tra la natura dell’obbligazione, se di risultato o di mezzi, perché, come buona parte della dottrina ha concretamente ritenuto, quando l’operazione è rutinaria, ed oggi l’ambito è molto più esteso rispetto al passato, o di facile soluzione come la maggior parte delle cure o degli interventi chirurgici più comuni, il risultato non solo è sperato ma deve essere raggiunto. Basti pensare a tutta la giurisprudenza che in tema di chirurgia estetica ritiene il risultato come obbligo contrattuale (Trib. Roma 14/1/1995, Gius. 1995, 643; Cass. Civ. Sez. II 8/8/1985 n. 4384; Cass. Civ. sez. II 21/6/1983 n. 4245); basti pensare a quelle indagini da effettuarsi con strumenti tecnologicamente avanzati la cui lettura è affidata ad un computer, dove il risultato può essere impedito solo dall’errore commesso dall’operatore. Se quindi la differenza tra le due obbligazioni prescinde dall’attività come genus ma dipende dalla tipicità della prestazione, è evidente che di fatto sia venuta meno e che a definire la responsabilità dell’operatore sia solo il modus con cui egli ha svolto la propria prestazione. E’ lo sforzo che la giurisprudenza, e in particolar modo la sentenza 589 della III Civile, fa per non uscire dalle norme codicistiche che regolano responsabilità e contratti ma è altrettanto evidente come per colmare quei vuoti, che il nostro ordinamento purtroppo contiene essendo vecchio rispetto all’esigenza attuale di giustizia, si ricorra sempre più spesso a locuzioni contrabbandate da diritti stranieri, tipo il contratto con effetti protettivi o al sofisma del diritto vivente, elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, quale risposta alle più pressanti ed attuali esigenze per cui anche la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, per quanto logica e giuridicamente esatta, non può costituire un punto definitivo, lasciando aperti altri spazi di indagine che riguardano, al di la della teoria, la quotidiana pratica dei diritti dei pazienti. Partendo dal punto fermo che è rappresentato dalla sentenza sopra commentata, se il rapporto tra medico e struttura ospedaliera da una parte e paziente dall’altra è un rapporto di natura contrattuale, le conseguenze che discendono non possono fermarsi alle sole conseguenze dannose ma anche alla inadempienza all’obbligo di curare, perché vi è anche e necessariamente da esaminare la parte prodromica al perfezionamento del contratto dalla quale possono determinarsi ulteriori conseguenze che soprattutto alla luce delle recenti conquiste giurisprudenziali in tema di consenso informato, acquistano un valore determinante. Prima che si instauri il cd. contatto sociale, quale fonte del rapporto obbligazionario tra medico e paziente, è necessario che entrambe le parti sappiano quale sia il fine della prestazione che andranno a pattuire e per farlo l’operatore deve erudire il creditore della prestazione circa la sua situazione clinica, le prospettive, le probabilità di successo, i rischi e le alternative fornendogli quindi un’informazione completa che lo metta in condizione di poter decidere secondo piena coscienza se sottoporsi o meno alla pratica medica consigliata. Io ritengo che questa fase preceda necessariamente il perfezionamento del contratto così come avviene in tutti i contratti a prestazioni corrispettive dove alla proposta (informazione) segue l’accettazione (consenso). Siamo quindi in ambito precontrattuale e cioè in quell’ambito la cui formazione rende operante ed efficace il contratto che ne discende. Quale elemento costitutivo quindi della espressione della libera volontà delle parti contraenti il consenso ne è uno dei requisiti fondamentali indubbiamente richiamato dall’art. 1325 del Codice Civile. La Cortedi Cassazione si è già espressa sul punto con la sentenza 25/11/1994 n. 10014 della III civile che richiama il principio della buona fede di cui all’art. 1337 c.c. nella trattativa precontrattuale. Non a caso il giudice, laddove si alleghi una incompleta, errata o del tutto mancante informativa da parte del medico che ha viziato il consenso del paziente, indaga circa la comune volontà e sull’ampiezza dell’informazione stessa né più e né meno di come prevede l’art. 1362 stesso codice. Il problema è di non poca rilevanza dal momento che il consenso rende lecito l’intervento medico altrimenti illecito perché in violazione dell’art. 5 c.c. e degli artt. 13 comma 1 e 32 comma 2 della Costituzione che tutelano l’inviolabilità della libertà personale e l’autodeterminazione. Se quindi manca la causa lecita inevitabile è la nullità del contratto stesso ai sensi dell’art. 1343 c.c.. Consegue naturalmente che l’intervento terapeutico, specie se modificativo o comunque lesivo della persona quand’anche finalizzato a curare il male, se non autorizzato in forza di un consenso ampio ed informato, annullandosi ex tunc la validità del contratto, determini la illiceità del trattamento sanitario e quindi automaticamente attribuisca al paziente il diritto al risarcimento per i danni subiti non solo quale conseguenza del trattamento sanitario indebitamente subito, che può aver anche raggiunto il successo, ma per la semplice violazione del diritto a liberamente decidere di come disporre del proprio corpo. In tal senso di recente se è espresso il Tribunale di Napoli con la sentenza 11/2/1998, inedita, ma fortunatamente inviatami dal caro amico Michele Liguori. Per fare un esempio attuale ricordiamoci della accesa disputa tra la scelta delle cure tradizionali chemioterapiche e la cd. cura Di Bella. Pensiamo al caso di quell’ammalato che si è sottoposto ad un lungo, distruttivo, doloroso ciclo di chemioterapia massiva, ritenendola l’unica soluzione clinica esistente quando invece una più ampia informazione del medico curante gli avrebbe consentito di decidere di optare anche per la terapia Di Bella e quindi trascorrere gli ultimi periodi di vita in serenità e tranquillità. Di fatto è quello che il Pretore Mandaro ha sostenuto nella famosa ordinanza che ha disposto la fornitura gratuita dei farmaci del Prof. Di Bella in forza di quella tutela del diritto alla salute e dell’autodeterminazione rispettivamente sanciti dagli artt. 32 e 3 della Costituzione (Pret. Lecce, Ez. Maglie-Ord. 11/2/1998, Guida al Diritto n. 12, 24). Nulla di più facile che si possa sostenere la violazione del diritto all’autodeterminazione qualora, nel prospettare la terapia, il medico non abbia illustrato anche le alternative, quand’anche da lui non condivise, di quei protocolli Di Bella per cui il consenso alla chemioterapia risulterebbe viziato perché frutto di una parziale informazione. Questa tutela estrema del diritto alla salute da noi è ancora quasi del tutto inesplorata a differenza dei paesi stranieri come gli U.S.A. dove la tutela dei diritti è prioritaria rispetto alla tutela delle conseguenze dovute alla violazione degli stessi. Basti pensare a quell’eclatante sentenza americana con la quale è stato ritenuto risarcibile, con svariati milioni di dollari, il solo timore di aver contratto l’A.I.D.S. anche se ciò non si era verificato: è evidente come sia stato tutelato il diritto alla serenità e il cd. danno esistenziale, figura che da noi sta prendendo forma quale estensione illimitata del danno morale, come meglio illustrerà il Prof. Monaderi nella prossima sessione. La stessa sentenza più volte richiamata della Suprema Corte, anche se incidentalmente, già contiene il germe di questo principio laddove afferma che è riduttivo, per i diritti del danneggiato, limitare la responsabilità del medico all’ambito extracontrattuale da fatto illecito in quanto tale responsabilità non sarebbe azionabile in mancanza di un danno, cioè di un evento peggiorativo. Ciò lascia supporre che l'illuminata Corte di Cassazione, nello sforzo ermeneutico di travalicare i limiti del diritto vigente onde parificare i diritti dei cittadini rispetto a posizioni preminenti e a volte vessatorie, arriverà prima o poi a tali pronunciamenti. Se poi a causa di un consenso viziato da una travisata informazione, il paziente si è sottoposto ad un intervento terapeutico che gli ha causato un danno ingiusto, le conseguenze saranno ancora più drasticamente evidenti e soprattutto di drammatica rilevanza penale. Non voglio occupare il campo d'indagine di chi dovrà parlare della responsabilità penale del medico, ma vale la pena di brevemente accennare a quella che, potendosi definire ipotesi scolastica, è l’estrema conseguenza per i medici in caso di decesso del paziente sottoposto a terapia senza valido consenso: l’omicidio preterintenzionale. La prima volta che nella storia del nostro diritto la cronaca giudiziaria si è occupata di simile ipotesi è il famoso caso “Massimo” dal nome del medico condannato con sentenza confermata dalla Cassazione Penale il data 13/5/1992 (In Resp. Civ. e Prev. 1993, 677). Si trattava del caso di un medico che dovendo operare all’intestino un’anziana donna, decideva, durante l’intervento, di asportarle anche un altro organo interno senza averne avuto il preventivo consenso. A causa di un errore commesso, la paziente poi decedeva. Secondo i giudici la responsabilità del Dott. Massimo era inquadrabile nell’ambito dell’omicidio preterintenzionale in quanto la mancanza del consenso aveva determinato la sussistenza del reato di lesioni volontarie cui era conseguita, quale evento non voluto, la morte. Meno noto è forse l’altro fatto di cui si è occupata recentemente la Cassazione e del quale attori principali siamo stati il Dott. Passacantando, oggi Procuratore Generale presso la Cassazione ed allora P.G. presso la Corte di Appello di Ancona, ed io come parte civile. Si trattava di un'operazione di chirurgia estetica effettuata in una casa di cura da un medico con il sistema cd. di liposcultura ad ultra suoni per ridurre i pannicoli adiposi in eccesso sul corpo di una giovane ragazza di 18 anni deceduta dopo 21 giorni di coma a causa di un'eccessiva dose di lidocaina. Poiché il chirurgo le aveva descritto l’intervento come rutinario, a rischio zero e, per la fase anestesiologica, una bassissima concentrazione di lidocaina, accogliendo il ricorso del P.G. e delle parti civili che chiedevano la riforma della sentenza della Corte di Appello che aveva, confermando sul punto la sentenza pretorile, condannato il chirurgo solo a titolo di omicidio colposo, la Corte di Cassazione, rinviando ad altra corte di merito per l’accertamento del reato di omicidio preterintenzionale, comunque ha affermato i principio che “il consenso al trattamento anestesiologico non può ritenersi presunto od implicito in quello dato all’intervento chirurgico ma deve essere specifico e frutto di adeguata ed altrettanto specifica informazione: l’ambito di questa invero si estende per tutta l’area necessaria ad evitare l’errore essenziale in concreto, quello cioè che abbia costituito condicio sine qua non della prestazione del consenso, fermo restando che l’elemento psicologico deve caratterizzarsi in senso doloso, anche eventuale e generico ma pur sempre con animus laedendi, potendosi altrimenti configurare il reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, quale ad esempio la violenza privata “ (Cass. Pen. Sez. IV 23/2/1998 n. 2233 inedita). Prescindendo dalla suggestione che il latinetto animus laedendi comporta, quello che rileva in questa decisione è che in caso di consenso viziato, l’indagine va svolta in merito all’errore essenziale nel quale il medico induce il paziente con una errata o volutamente incompleta informazione convincendolo a sottoporsi ad una terapia, comunque lesiva dell'integrità fisica, che si rivelerà invece di pregiudizio per la sua salute. Poiché la normale conoscenza medica, qualora sfruttata con diligenza proporzionale al problema trattato, fa sì che prevedibili siano le conseguenze dannose in caso di terapia a rischio, sussiste sempre il dolo eventuale o generico, che caratterizza l’elemento psicologico, così come sussiste inevitabilmente la volontà di ledere, nel senso di incidere il corpo umano malato, che è sempre presente in ogni intervento chirurgico anche se finalizzato al bene del paziente. Le conseguenze quindi del mancato consenso possono essere, a volte, veramente gravi. In pratica quello che conta nel rapporto medico-paziente, non è tanto l’aspetto di danno da colpa, quanto la libera volontà di sottoporsi ad una terapia che, per quanto benefica possa essere, è pur sempre lesiva dell'integrità della persona. A dimostrazione del rigore con il quale viene giudicato il problema del consenso da parte dei giudici penali, particolare è la recentissima sentenza di cui anche la stampa si è occupata con la quale la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. IV 21/3/1997 in Foro It. 1997, II, 761) ha condannato per rifiuto di atti di ufficio il medico ospedaliero, nella specie aiuto primario, che ha taciuto alla gestante informazioni riguardanti la salute del nascituro, affrontando per la prima volta il problema della responsabilità del sanitario ex art. 328 c.p. quale pubblico ufficiale e quindi tenuto ad un obbligo d'informazione la cui omissione equivale ad un rifiuto di atti di ufficio. Lascio al Dott. Passacantando, già autore di una eccellente monografia sulla rilevanza penale del consenso, il compito di addentrarsi negli interessanti per quanto gravi aspetti di questa specifica ipotesi per ritornare quindi a quello che più ci interessa e cioè la responsabilità sotto l’aspetto civile del medico. Peraltro la digressione non mi ha allontanato dal discorso fondamentale perché mai come in materia sanitaria l’illecito civile o la inadempienza contrattuale che dir si voglia, determinando quasi inevitabilmente una lesione alla persona del malato, perfeziona ipotesi di reato per cui trattare della responsabilità del medico solo sotto l’aspetto civilistico è un po’ come parlare di calcio senza parlare degli arbitri e delle sanzioni giuste e ingiuste che costoro comminano. Credo sia il momento di condensare il discorso riepilogando brevemente i principi finora ricordati che, riguardando le tipologie della responsabilità del medico, riguardano maggiormente anche il primario in posizione cd. apicale, il che lo rende soggetto di doveri ancor più ampi rispetto alle altre categorie degli operatori sanitari. In forza dell’art. 63 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, sullo Stato Giuridico del Personale delle U.S.L., al medico appartenente alla posizione apicale, spettano mansioni “medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell’unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. Al tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto dell’autonomia professionale operativa del personale dell’unità assegnatagli, impartendo all’uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente alla attuazione di esse. In particolare, per quanto concerne le attività in ambiente ospedaliero, assegna a sé e ai medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l’obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle atre posizioni funzionali. Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza. Le attività svolte dal medico della posizione apicale sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi e ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale sulla attività svolta”. Qui non interessa vedere che cosa sia mutato nell’ambito delle competenze del primario rispetto alla precedente normativa contenuta nell’art. 7 del D.P.R. 27/3/1969 n. 128, perché quello che ci occupa non è la storia dell’istituto del primariato bensì la responsabilità, per cui alla luce della attuale legislazione in tema è indubitabile che il primario abbia mansioni tipicamente dirigenziali, né più né meno quelle di un manager cui è affidata una struttura tecnologicamente avanzata, particolarmente a rischio e quindi da dirigere, controllare e correggere oltre che aggiornare con particolare attenzione e quindi eccezionale diligenza. Si comprende subito dalla lettura del sopra richiamato art. 63 come i compiti devolutigli siano di diversa appartenenza e quindi spazino tra un ambito eminentemente pubblicistico (rapporto tra primario e ente pubblico ospedaliero dal quale dipende), che determina una responsabilità amministrativa, e di ordine privatistico per tutto ciò che riguarda il contatto sociale che quotidianamente il primario ha, direttamente o indirettamente, con i pazienti e ciò non solo negli interventi diretti e personalmente prestati ma anche per quella inevitabile responsabilità che di rimbalzo gli deriva per quanto commesso dai suoi sottoposti in virtù del rapporto organico che esiste nel reparto da lui diretto. Il primario infatti non si limita a dirigere il reparto, ma ne deve curare anche l’aggiornamento con “attività di studio, di didattica e di ricerca”, esercitando anche “funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura……impartendo all’uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerenti all’attuazione di esse”. C’è quindi, per la preminente posizione apicale assunta dal dirigente, tutta una serie di attività di direttive, di controllo e di verifica anche sull’opera degli altri componenti, che trova limite “nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale dell’unità assegnatagli” limite che però è superabile con la potestà di “avocare casi alla sua diretta responsabilità” allorquando evidentemente il suo parere contrasti con quello autonomamente espresso dai suoi ausiliari. Alla responsabilità diretta per i fatti direttamente commessi si aggiunge per il primario anche quella dipendente da quel dovere non solo di vigilanza e controllo ma addirittura di assumersi la diretta trattazione del caso quando ritenga errata o inadeguata l’opera del proprio sottoposto. La violazione di tali precetti costituisce in colpa il primario e la giurisprudenza lo ha affermato più volte anche se quasi sempre dal punto di vista penale. E’ infatti responsabile il primario che nell’esasperazione del rispetto della autonomia decisionale e operativa del proprio aiuto, non intervenga assumendosene l’onere, avocando a sé il trattamento terapeutico e quindi di fatto concorrendo per omissione alla causazione del danno per il paziente (Trib. Firenze 25/5/1981 Diritto e Pratica Assicurazioni 1981,698; Cass. Pen. 2/5/1989, Foro It. 1989, II, 600), così come è stato ritenuto responsabile il primario che ha omesso di verificare tempestivamente l’esattezza della diagnosi, e la precisione della terapia effettuate da un suo aiuto (Cass. Pen. 22/9/1989 in Giust. Pen. 1990, II, 476). Un'altra ipotesi di responsabilità che fa carico al primario, quale dirigente della struttura del reparto, è quella di controllo della perfetta efficienza degli strumenti tecnici in dotazione, dal cui difettoso funzionamento può discendere un danno ai pazienti. Si veda da ultimo la recentissima sentenza del Tribunale Penale di Milano che ha condannato per il rogo dell’ospedale Galeazzi anche il primario colpevole di non aver vigilato sul perfetto funzionamento della camera iperbarica e sugli strumenti di sicurezza destinati a prevenire e scongiurare gli incendi. Quindi questo dirigente apicale ha anche un compito di vigilanza tecnica che può effettuare direttamente o a mezzo di esperti il cui scopo però è quello di prevenire le carenze di funzionamento e quindi il danno al paziente. Si è ritenuto addirittura colpevole il primario di una struttura sanitaria per non aver dotato il reparto di ginecologia di un moderno strumento di indagine computerizzata, in dotazione ad altri ospedali e quindi di comune utilizzo, l’uso del quale avrebbe evitato l’errata diagnosi e quindi il danno alla paziente (Trib. Milano 19/5/1992 in Resp. Civ. e Prev. 1994, 157). L’altro giorno parlavo con l’amico Alberto Polotti di Zumaglia delle conseguenze che in ambito civilistico e assicurativo potrebbero derivare al primario dal fenomeno attualissimo del Millenium Bug. Il problema è noto a tutti e riguarda il caos informatico che pare inevitabilmente colpirà, come una sorta di amnesia, tutti i sistemi informatici che, per quanto intelligenti siano, non sono in grado di leggere lo 000, cioè il cambio di data del millennio. Io di questioni informatiche non capisco nulla per cui non sono in grado di dire come il problema può essere ovviato o risolto, ma con Polotti, che poi vi parlerà in modo più diffuso e approfondito delle conseguenze di ordine assicurativo, abbiamo posto il discorso sotto l’aspetto della responsabilità che il fenomeno può comportare qualora ne derivi danno a cose o a persone. Facciamo il caso della banca dati di un ospedale che contiene lo scadenzario delle terapie o degli interventi di urgenza; di quelle strumentazioni computerizzate che pare inevitabilmente andranno in black out al passaggio di data tra il 31/12 e il 1/1/2000. Poiché il primario, come abbiamo sopra detto, ha un obbligo di vigilanza e controllo sulle attrezzature tecniche, credo che ne possa derivare a lui una ipotesi di responsabilità qualora non abbia preteso e controllato che l’amministrazione ospedaliera approntasse quelle tutele per eliminare le conseguenze del millenium bug e quindi far sì che le attrezzature informatiche funzionino ugualmente. Se quindi il dirigente apicale, che confortato dal solo fatto che direttive ministeriali impongono alle amministrazioni pubbliche di adeguare i sistemi informatici, non abbia poi controllato che tale soluzione sia stata adottata positivamente, risponde delle conseguenze dannose che l’omissione del suo datore di lavoro può aver causato al paziente, a titolo di omessa vigilanza e quindi per violazione di quelle funzioni che gli sono demandate dall’art. 48 della L. 833 del 1978. Sul numero 43 di Guida al Diritto del 6/11/99 vi è un interessante articolo di Gian Luigi Ciacci sugli aspetti giuridici e amministrativi del fenomeno. Sarebbe interessante potersi addentrare nella disamina dei diversi aspetti della responsabilità facente capo al primario, del concorso della responsabilità del primario con quella dell’anestesista, del primario come responsabile dell’equipe chirurgica, per constatarne la sfumatezza dei limiti e quindi l’ampia discrezionalità interpretativa, che a volte si trasforma in arbitrio. Basta domandarsi fino a che punto l’autorità del primario si evolve in potere coercitivo e fino a che punto egli è tenuto al rispetto della altrui autonomia. O verificare fino al che punto sia tenuto l’aiuto a rispettare le direttive impartitegli dal primario, se quindi abbia un dovere assoluto di obbedienza o possa, pur conscio di aprire un conflitto pericoloso, agire al di fuori delle direttive impartite. Ma il tempo stringe e spero di averne dopo per discuterne con voi nel dibattito che seguirà. Se gli aspetti della responsabilità civile del primario, anche se ampliata perché in lui si riverberano anche ipotesi di culpa in vigilando, tutto sommato poco si discostano, per radice contrattuale, con quelle degli altri medici ospedalieri, diverse sono quelle che a lui fanno carico per la mancata osservanza di quegli adempimenti che, in veste di pubblico ufficiale, egli è tenuto ad espletare e per i quali risponde a titolo di responsabilità amministrativa o per particolare ipotesi di delitto commesso da pubblico ufficiale. Su tale qualifica ormai vi è comunanza di opinioni posto che, soprattutto nell’espletamento delle funzioni istituzionalmente demandategli, il primario è indubbiamente un pubblico ufficiale perché partecipa direttamente con la pubblica amministrazione alla realizzazione degli scopi socialmente rilevanti previsti dalla legislazione in materia di sanità pubblica: egli in pratica è l’emanazione operativa attraverso la quale lo Stato realizza la funzione assistenziale sanitaria. Tralascio di addentrarmi nell’esame di particolari aspetti delle responsabilità penali a titolo pubblicistico che fanno carico al primario quali il peculato, la malversazione, l’abuso o l’omissione di atti di ufficio per parlare brevemente, perché sotto l’aspetto pratico più cogente della materia della quale parliamo, dei reati di falso che possono essere addebitati al primario per la modifica della cartella clinica perché è uno strumento importantissimo non solo per individuare la responsabilità penale ma anche e soprattutto per assolvere a quell’onere probatorio che, nonostante la dilatazione della responsabilità del professionista medico, continua per gran parte a far carico al paziente danneggiato. Si è ritenuto in passato che la cartella clinica altro non fosse che un diario cronologico, edito in forma di scrittura privata, valida ai fini probatori solo se contenente dati contrari agli interessi del medico, ma oggi si afferma che la cartella clinica sia un atto pubblico e che faccia fede sino a querela di falso la cui tenuta riverbera nel primario l’obbligo di fedelmente riportarvi, o di farvi riportare, tutte le annotazioni relative all’anamnesi, alle cure e terapie durante e dopo il ricovero ospedaliero. Capita spessissimo che questo documento susciti se non sospetti, perplessità sulla autenticità perché resta a disposizione del medico fino a quando non se ne chiede copia, e la si ottiene non certo con sollecitudine, o non venga sequestrata dal Pubblico Ministero. Sospettare quindi che nel frattempo possa essere stata modificata per eliminare la prova dell’errore o attenuarne la portata, è più che legittimo. Si è sostenuto che finché la cartella è nella disponibilità del suo redattore, prima quindi che venga pubblicata e messa a disposizione, può essere modificata e corretta, in quanto tutto sommato altro non sarebbe che la sintesi di quanto avvenuto la cui portata probatoria vale soltanto in quanto tale sintesi sia ultimata e l’elaborato depositato. Di contro si può senz’altro affermare che proprio per la particolare cronologicità con la quale i fatti clinici devono essere riportati nel diario giornaliero, e per la successione dei periodi (diagnosi di ingresso, anamnesi, accertamenti e diagnosi definitiva, terapia, diagnosi di dimissione), successive correzioni altro non sarebbero che modificazioni di quanto giornalmente elencato e quindi veri e propri falsi. Da questa ipotesi discendono due tipi di responsabilità diretta verso l’Ente pubblico per violazione del rapporto fiduciario che lega il primario al servizio sanitario locale, di responsabilità penale per il reato di falso in atto pubblico ed infine di responsabilità civile nei confronti del paziente per la malafede e quindi il dolo che aggrava la responsabilità del sanitario. Per concludere questa veloce galoppata nel campo della responsabilità medica, mi sembra che si possa trarre una conclusione: se anche il concetto di colpa del sanitario oggi è più ampliato rispetto al passato, quando ne venivano esaltate le giustificazioni morali e il fine di bene che comunque l’arte medica si prefiggeva, rimane pur tuttavia limitata da quelle barriere costituite dalle ipotesi di dolo o colpa grave che, almeno in teoria, sono sopravvissute anche alla più attuale rivisitazione operata dalla Suprema Corte. In una professione esposta a grandi rischi quale è quella del medico, che deve decidere e operare a volte sul filo dei secondi, è indubbio che l’ordinamento ne debba tutelare la sicurezza onde evitare che la paura dell’errore e delle conseguenze, possano pregiudicare il risultato e attenuare lo sforzo del professionista, ma è altrettanto evidente che il malato debba essere assolutamente tutelato da quegli errori e dai quei comportamenti che sempre più spesso, e mai come oggi, sono definiti frutto della malasanità. La decadenza delle strutture pubbliche, la inadeguatezza dei compensi, la mancanza di professionalità purtroppo sono le cause prime della drammatica situazione della sanità nel nostro paese, alla quale, come sempre, si è tentato di mettere pezze politiche ma non di radicalmente ristrutturarla. La maggior severità che trapela dalle applicazioni giurisprudenziali non è tanto tesa a eliminare la cd. “malasanità”, quanto a far sì che il malato abbia piena tutela dei suoi diritti e possa pretendere ed ottenere un congruo risarcimento. *Avvocato giurista, Ancona |
|